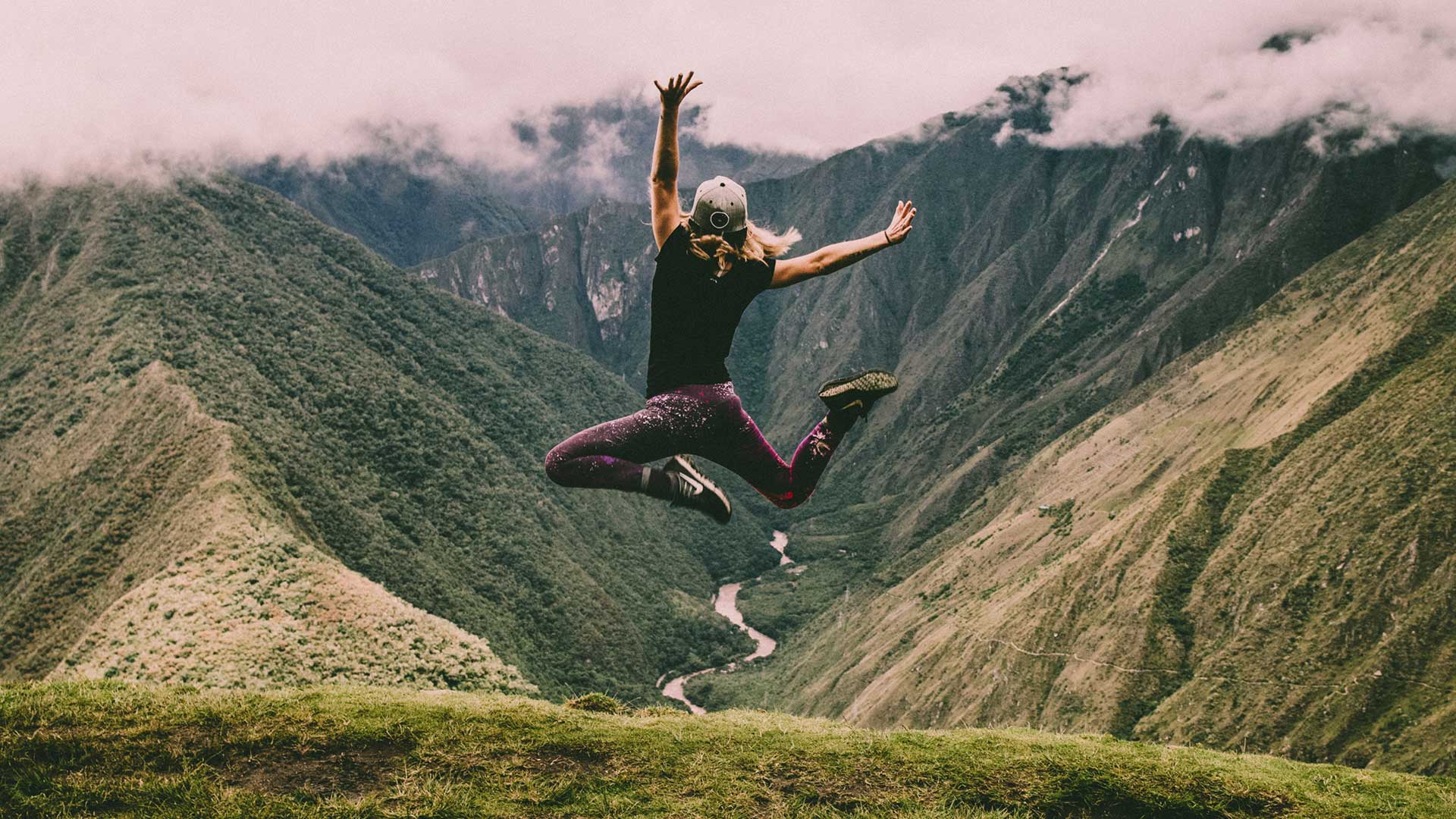
Un valore inestimabile
Se davanti al dolore rimaniamo muti, un problema c'è. Se davanti alla sofferenza di qualcun altro ci voltiamo dall'altra parte, un problema c'è. Forse è mancanza di empatia. Forse è mancanza di coraggio. Oppure è lo switch-on della nostra società: tutti chini su uno smartphone, ognuno immerso nel proprio mondo. O, ancora, è l'abbandono del contatto con l'altro, dell'incrocio di sguardi che tanto dischiude sulle verità di ciascuno.
Una decina di giorni fa, il 13 giugno precisamente, si è consumata una vicenda atroce in provincia di Catania, dove una madre di 24 anni ha ucciso la propria figlia di 5 anni. Non esistono parole davanti ad atti del genere, perché le stesse parole sono armi taglienti che possono ferire, sanguinare, fare male. C'è chi parla di omicidio premeditato, chi di vendetta nei confronti dell'ex compagno. Solo supposizioni che hanno poco, se non nessun fondamento di verità. Ma, d'altronde, la vita non è nient'altro che una supposizione: non sai cosa potrà accadere domani, però limiti l'ignoto pianificando, edificando una strategia, cercando di prendere il controllo. Eppure, il controllo spesso sfugge, è un volante che guida da solo, e tu ti illudi di poter controllare quello che, in realtà, è un pilota automatico.
Spesso, per limitare le nostre paure, preferiamo non vederle, come se non esistessero. Di questa finzione, però, le nostre paure si nutrono. Acquisiscono tutto il loro sostentamento e, al momento opportuno, colpiscono. Come un cecchino dall'alto di una montagna: aspetta, paziente, il nemico. Non ha fretta, lui, di colpire, perché sa che quell'unico colpo che scaglierà, sarà fatale. Le nostre paure, se non accettate, diventano i nostri cecchini. Un cecchino che, però, non si palesa. Un cecchino che si nasconde dietro un altro sentimento: il capro espiatorio di ogni nostro malessere. Ora il caldo, ora lo stress, ora la stanchezza, ora il lavoro, ora il troppo studio. C'è sempre una causa da rintracciare, un elemento scomposto del puzzle. Ma, chi è che fa questo puzzle?
Paradossalmente, l'io, come soggetto, non lo usiamo quasi mai. Utilizziamo una comunicazione molto passiva e poco assertiva per cui, in realtà, è come se delegassimo il compito di vivere a qualcun altro. Sconfitte? Ostacoli? Non siamo noi che li affrontiamo, è la stanchezza-stress-caldo a farlo per noi. Nella nostra vita, noi non esistiamo. Ci siamo, ma solo come mere risposte fisiologiche agli eventi che viviamo. E, come potremmo mai accettare la vulnerabilità dell'essere umano, i conflitti, l'eccentricità, i traumi, le emozioni se nemmeno ci poniamo al centro della nostra vita? Allora, più facile opinare sulla vita degli altri, che vedere le proprie voragini interne, e rischiare di caderci dentro.
Eppure, non c'è ferita che non possa essere curata con la stessa vita.
La vita è come un'eco: se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii.
recita una famosa frase di James Joyce. I veri comandanti di questa nave siamo noi: la nostra coscienza narrativa pensa attraverso le parole che noi le diciamo di utilizzare. E, tutto ciò che non diciamo, tutto quello che preferiamo far tacere, che zittiamo per il troppo carico emotivo che emana si trasforma in trauma: irrompe nella coscienza narrativa, spezza il flusso di vita e vitalità.
Ma, anche davanti a questa presunta o possibile sofferenza, voltarsi di spalle non è mai la soluzione. Anzi, ingigantisce l'apice del problema. Quello che proprio non capiamo o accettiamo troppo tardi è che la vita è un valore inestimabile, ha un valore inestimabile. La vita è la nostra opportunità, il nostro riscatto, la nostra forza. La sofferenza è il prezzo che dobbiamo pagare per vivere appieno. Perché senza dolore, senza emozioni, si vive una vita che non sa di vita.
